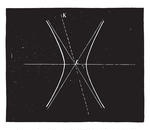In un 2018 mediamente avaro di pellicole di spessore, il pluripremiato lavoro di Martin MacDonagh Tre manifesti a Ebbing, Missouri rischia di rappresentare una delle poche eccezioni nonché una piacevole sorpresa. Non solo per la mole di premi vinti (miglior attrice e miglior attore non protagonista agli Oscar, miglior sceneggiatura al Festival di Venezia e miglior film drammatico ai Golden Globe, solo per citarne alcuni) quanto per l’originalità e l’intelligenza di una sceneggiatura brillante, cinica e ironica. Se poi si aggiunge l’interpretazione di una gigantesca Frances McDormand, magistralmente assistita dalla ormai assodata bravura di Whoody Harrelson e dalla sorpresa Sam Rockwell, il risultato non poteva che essere positivo.
 Tre manifesti narra la storia di Mildred Hays, madre di una figlia stuprata e uccisa. Un crimine irrisolto che in città sembra non suscitare più l’interesse di nessuno ad eccezione di Mildred. Così, dando fondo ai suoi risparmi, commissiona tre manifesti provocatori indirizzati allo sceriffo Willoughby, per spronarlo affinché le indagini proseguano e dividendo l’opinione pubblica di Ebbing.
La crociata di Mildred contro la polizia – accusata di occuparsi più del maltrattamento dei neri e degli omosessuali che di risolvere l’omicidio della figlia – risveglia l’assopita coscienza della comunità di Ebbing, i cui cittadini più influenti si schierano però dalla parte del rispettabile sceriffo Willoughby, dando così occasione all’anarchica Mildred di dar sfogo a tutto il suo dolore in un crescendo di dialoghi al vetriolo e di vendette personali.
Certamente il tema dell’odio razziale, che ancora imperversa nelle province dell’america profonda, attraversa tutta la pellicola, e può essere riassunto nella battuta con il quale lo sceriffo risponde alle lamentele di Mildred: ” Se dovessimo cacciare dalla polizia tutti quelli che odiano i neri ci ritroveremmo con tre o quattro poliziotti che comunque non sopportano i froci”.
Tre manifesti narra la storia di Mildred Hays, madre di una figlia stuprata e uccisa. Un crimine irrisolto che in città sembra non suscitare più l’interesse di nessuno ad eccezione di Mildred. Così, dando fondo ai suoi risparmi, commissiona tre manifesti provocatori indirizzati allo sceriffo Willoughby, per spronarlo affinché le indagini proseguano e dividendo l’opinione pubblica di Ebbing.
La crociata di Mildred contro la polizia – accusata di occuparsi più del maltrattamento dei neri e degli omosessuali che di risolvere l’omicidio della figlia – risveglia l’assopita coscienza della comunità di Ebbing, i cui cittadini più influenti si schierano però dalla parte del rispettabile sceriffo Willoughby, dando così occasione all’anarchica Mildred di dar sfogo a tutto il suo dolore in un crescendo di dialoghi al vetriolo e di vendette personali.
Certamente il tema dell’odio razziale, che ancora imperversa nelle province dell’america profonda, attraversa tutta la pellicola, e può essere riassunto nella battuta con il quale lo sceriffo risponde alle lamentele di Mildred: ” Se dovessimo cacciare dalla polizia tutti quelli che odiano i neri ci ritroveremmo con tre o quattro poliziotti che comunque non sopportano i froci”.

Tuttavia, MacDonagh, al contrario di quanto scritto da alcuni, è sembrato più interessato ad indagare la costitutiva contradditorietà e ambivalenza dell’umano piuttosto che consegnarsi alla polemica, seppur dovuta e sempre attuale, della mancata attuazione dei diritti sanciti dal Civil Rights Act.
L’ossessione e la sete di giustizia di Mildred fanno da sfondo a una più profonda e scaltrita analisi della dimensione antropologica. Evitando di scadere in facili retoriche e contrapposizioni manichee, Martin MacDonagh attinge al cinema d’autore per giungere infine alla sua personale sintesi estetica. I debiti nei confronti dei Cohen (la scelta dell’ambientazione negli stati profondi, il volto di Frances McDormand e le splendide musiche di Carter Burwell) sono vistosi e immediatamente rintracciabili, ma a differenza dei fratelli di St. Lous Park, il piglio con cui il regista affronta il dolore e la vendetta mostra una tendenza meno incline a sfociare nel grottesco e soprattutto una sensibilità che va al di là della battuta corrosiva e dell’insulto divertente, sebbene il ricorso a questi elementi abbia finito per rappresentare una carta d’identità del suo cinema. Un debito meno evidente ma non per questo meno eloquente è quello nei confronti del cinema di Clint Eastwood. A testimoniarlo, oltre alla generale atmosfera anarco-capitalista che permea tutto il racconto, è la caratterizzazione di Mildred, che ricorda molto il personaggio di Walt impersonato da Eastwood in Gran Torino. Entrambi, mentre esibiscono con cinica ruvidità la volontà lucida di scontrarsi con la realtà, non mostrano però altrettanta spregiudicatezza nell’affrontare i propri demoni interni. La rabbia accumulata, l’odio e il dolore vengono così celati dietro una maschera di aggressività sofferta che sfocia nella battuta anticonformista ed elettrica, ma che tuttavia non riesce a stemperare l’amara sensazione di solitudine che li accompagna.

Ciò che colpisce maggiormente del film di MacDonagh è la capacità di mantenere l’ambivalenza della dimensione umana, rinunciando ad appiattire il carattere dei personaggi, imprigionandoli in ruoli definiti e facilmente etichettabili. Le tre lettere inviate dallo sceriffo morente, oltre a mostrare una struggente sensibilità, sono indicative di come il regista sia riuscito a trasmettere la tensione drammatica e l’evoluzione psicologica dei personaggi, che a un certo punto diventa quasi straniante e che infine conduce verso un finale inatteso, aperto e indefinito. Il bene e il male possono essere sfumati e sempre suscettibili di essere revocati in dubbio. In questo modo la tragedia, che è il vero protagonista del film, viene edulcorata travestendosi da black comedy, e nonostante la fluviale esibizione verbosa e i brillanti dialoghi ci viene restituita la consapevolezza di una cruda verità: e cioè che la scelta tra bene e male è sempre una questione umana, troppo umana.